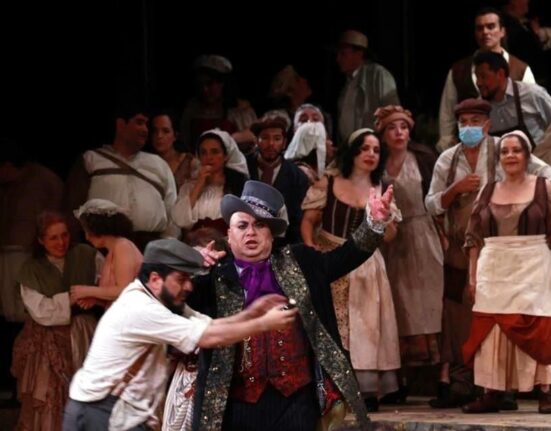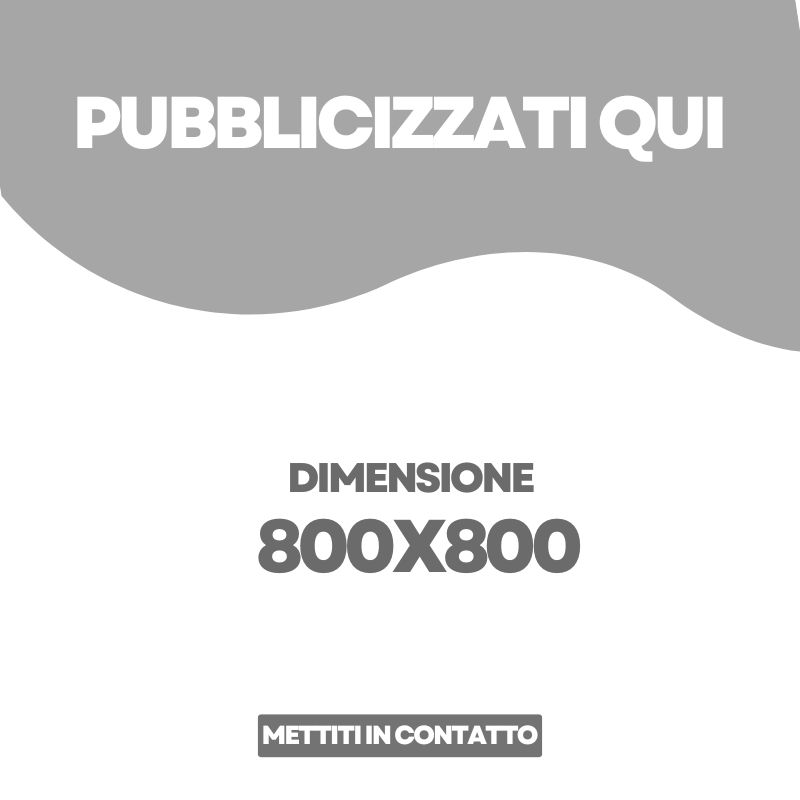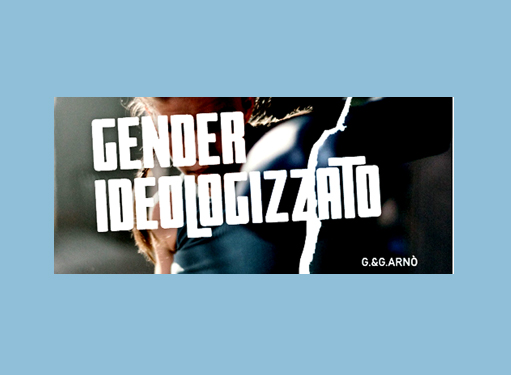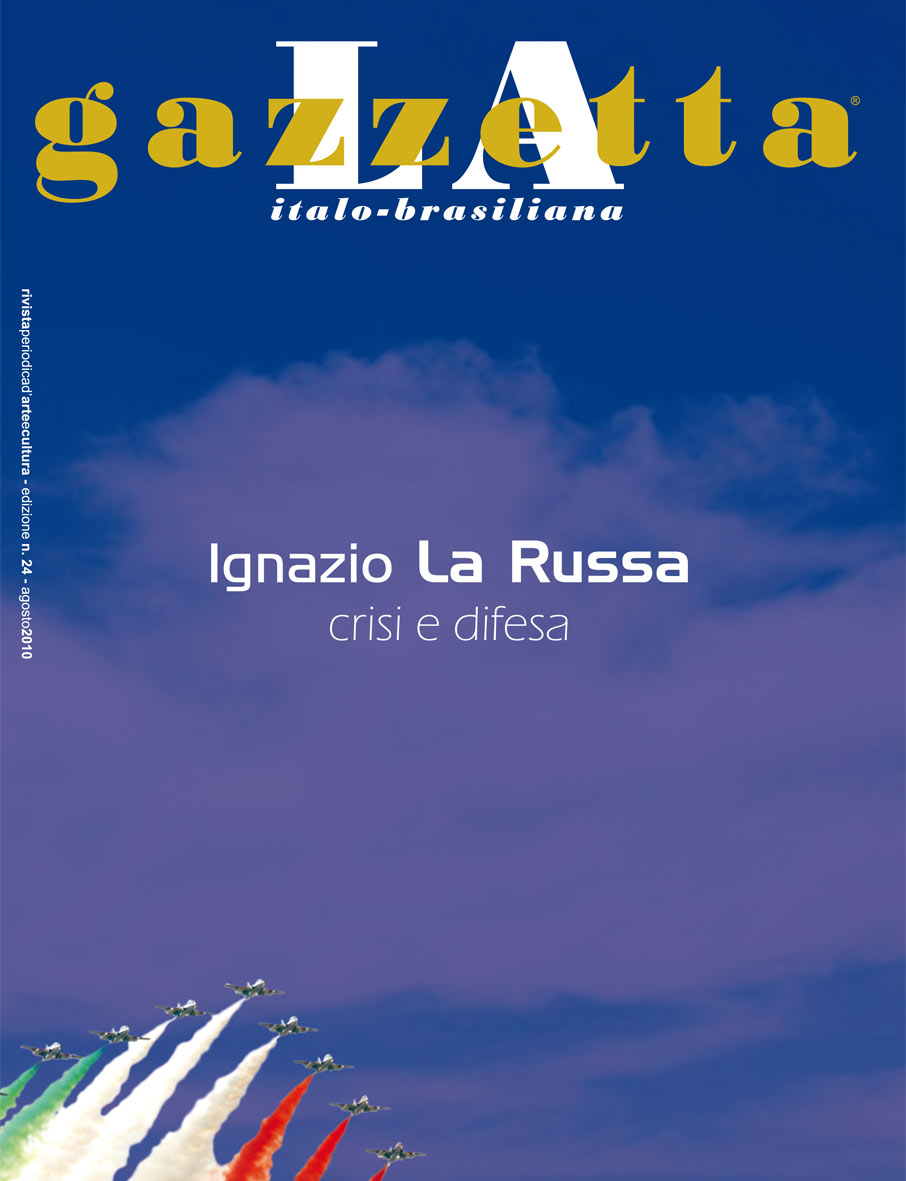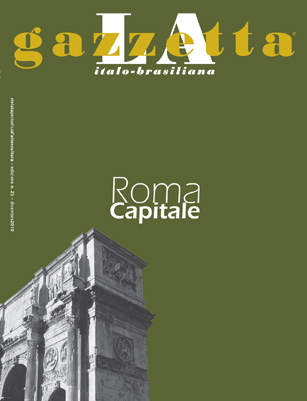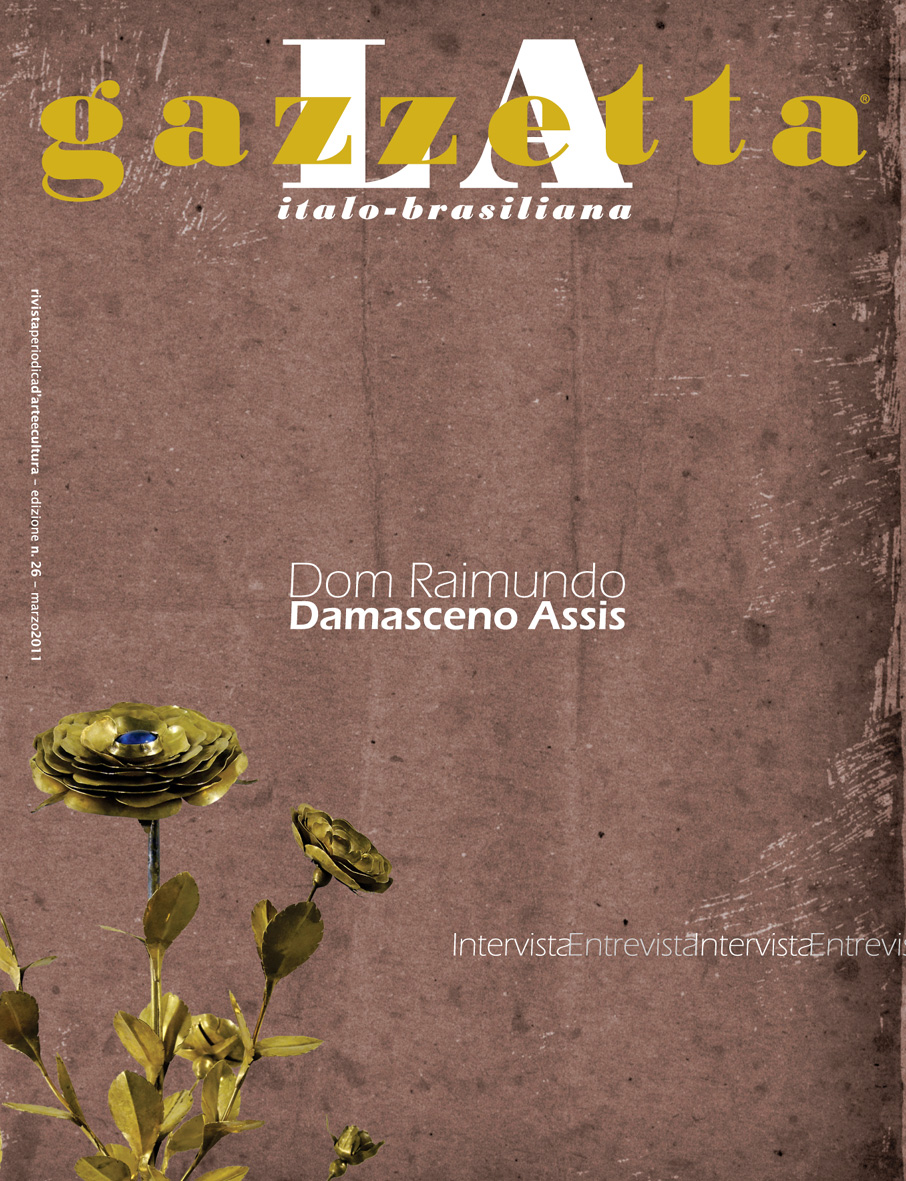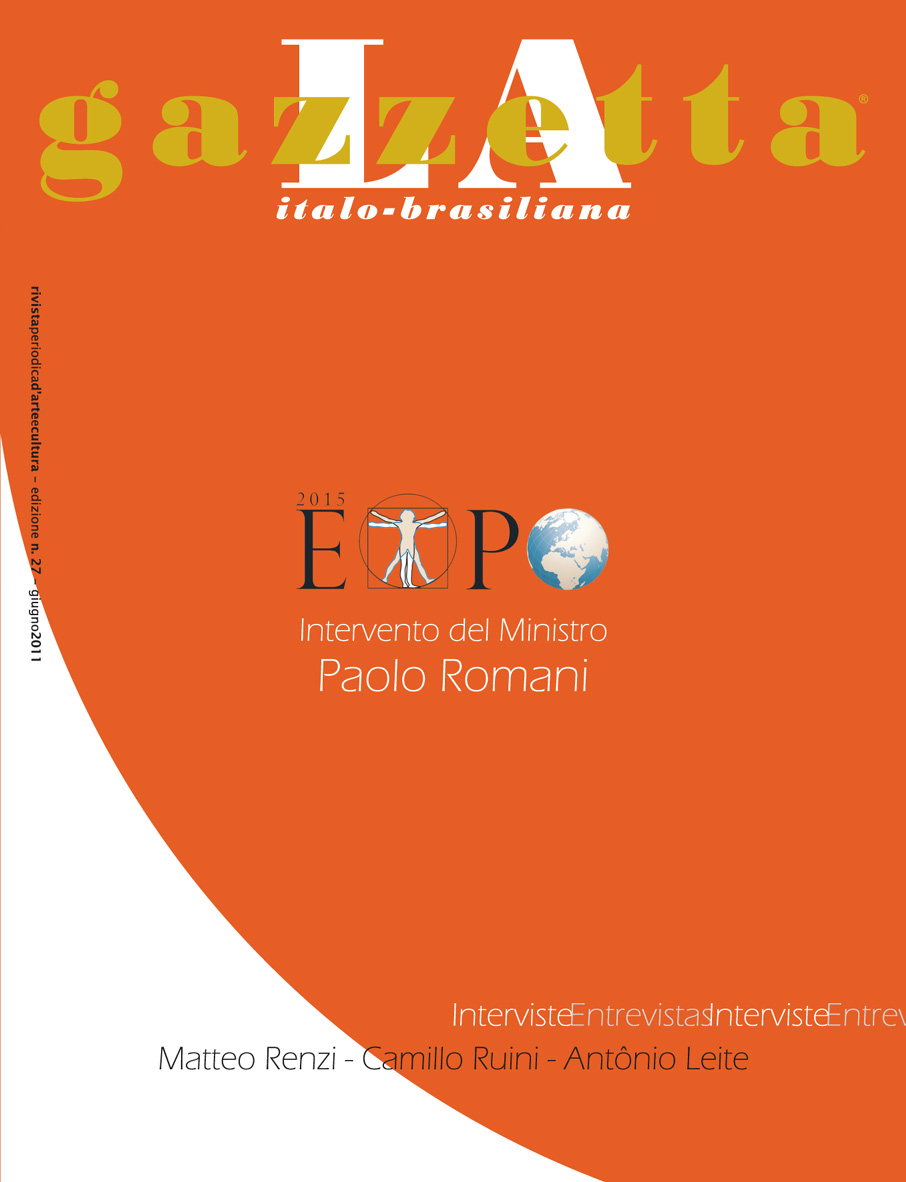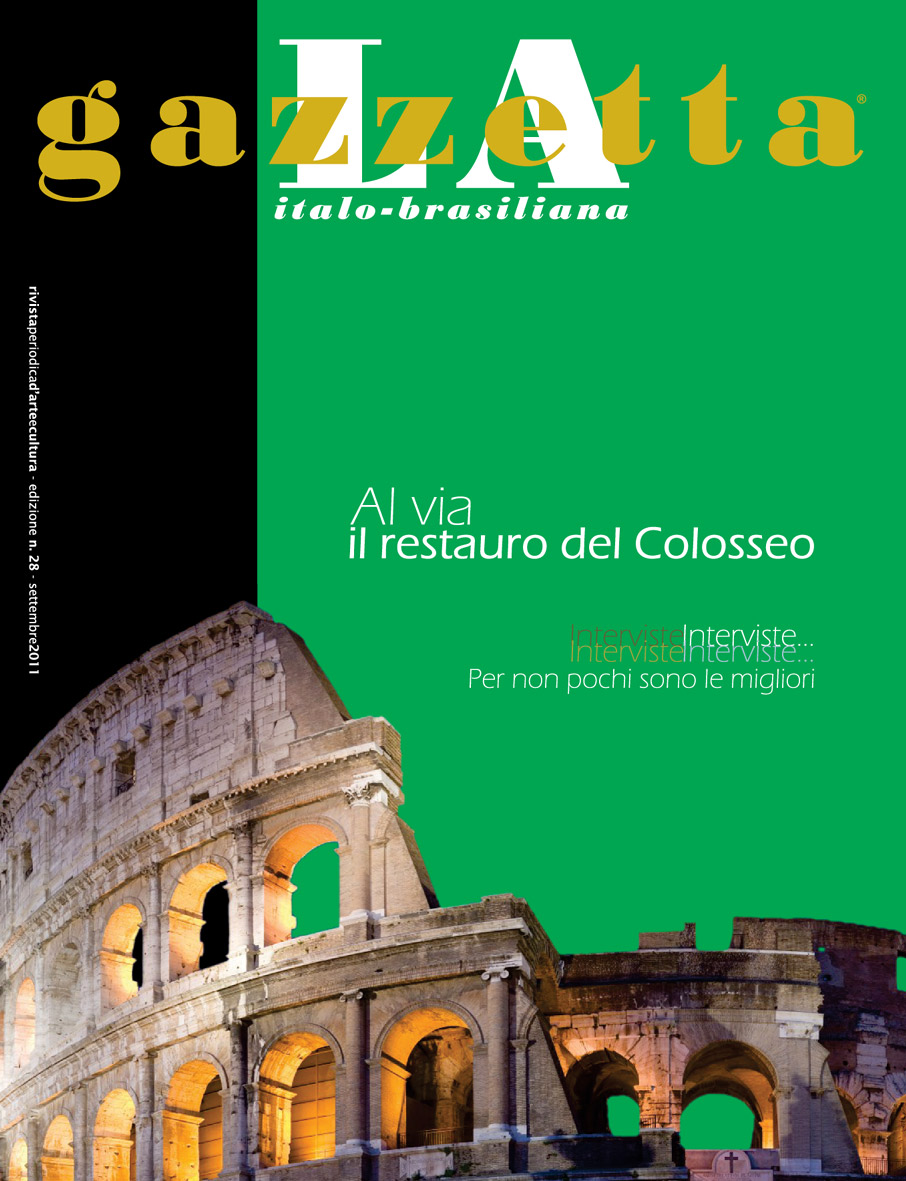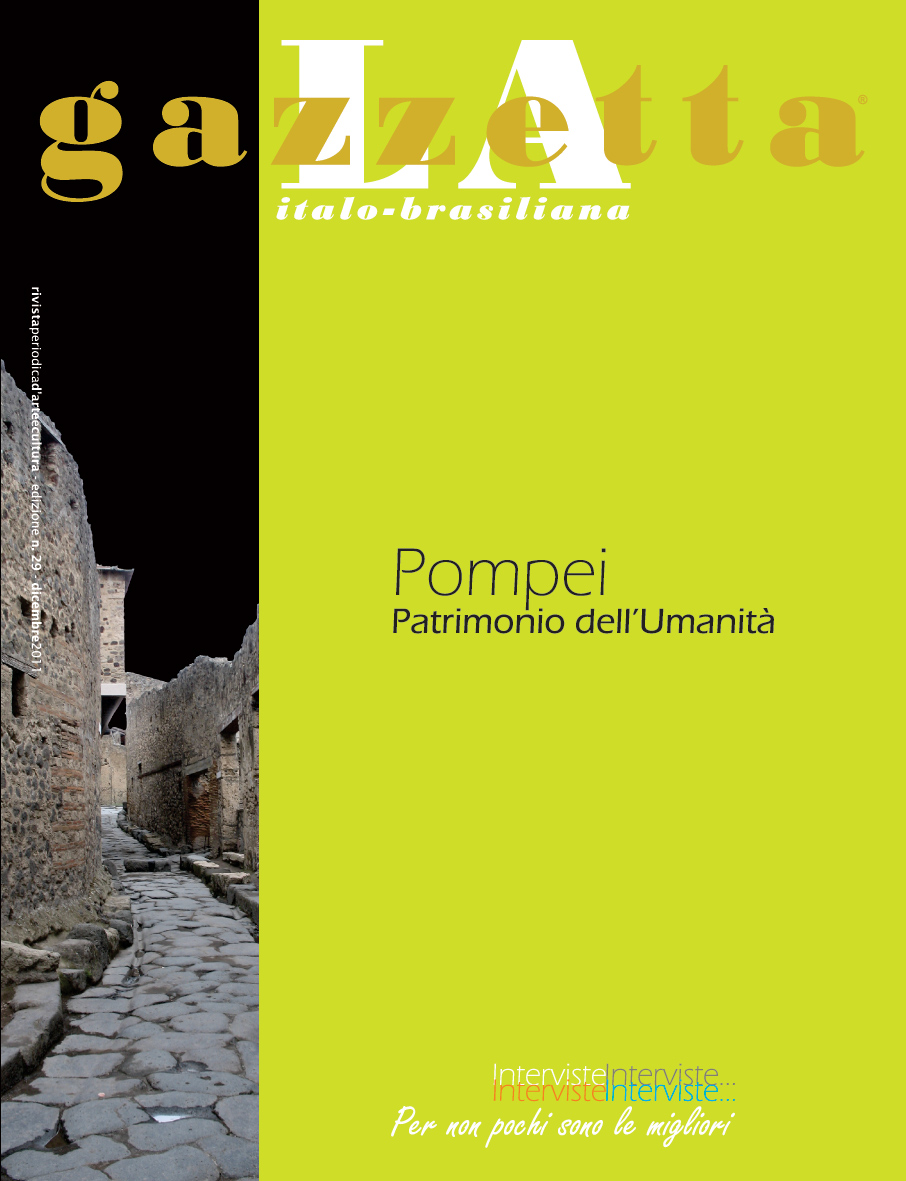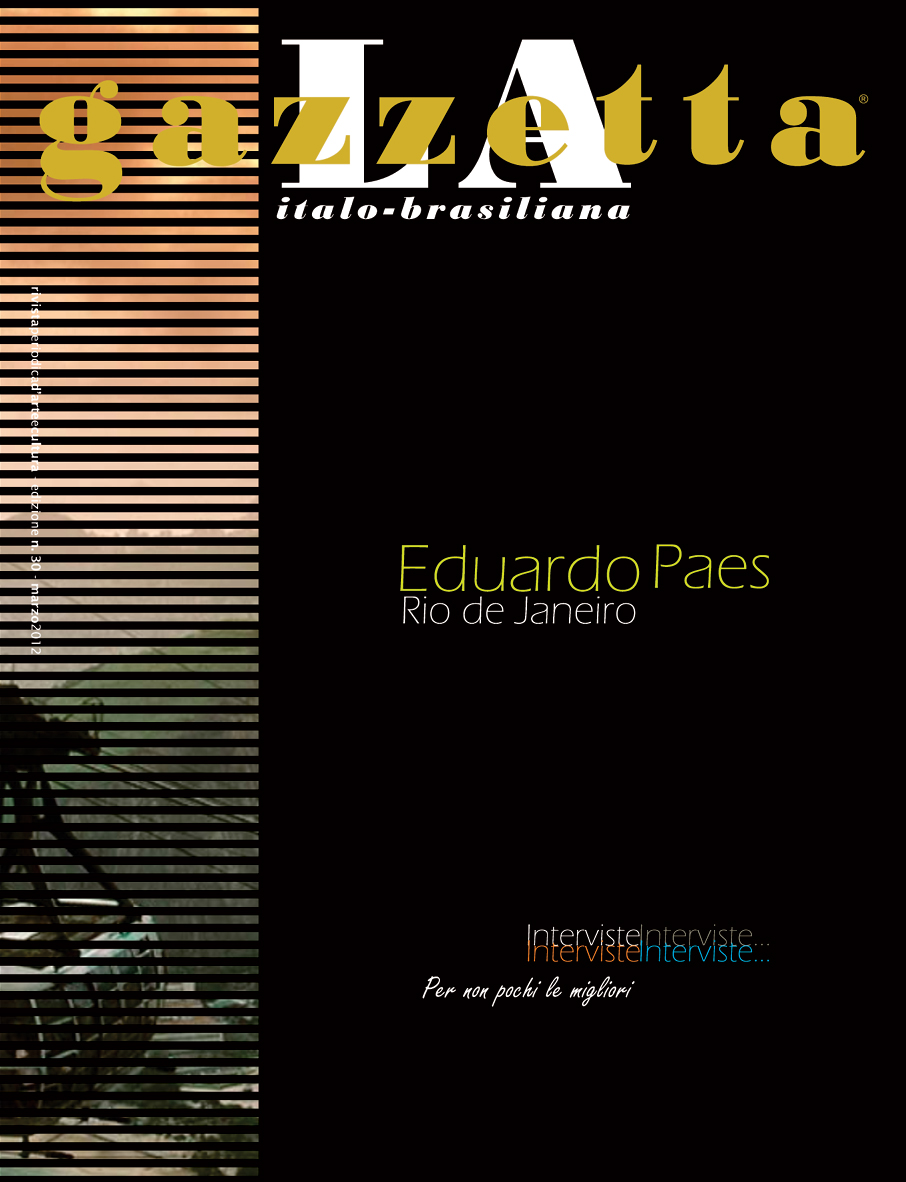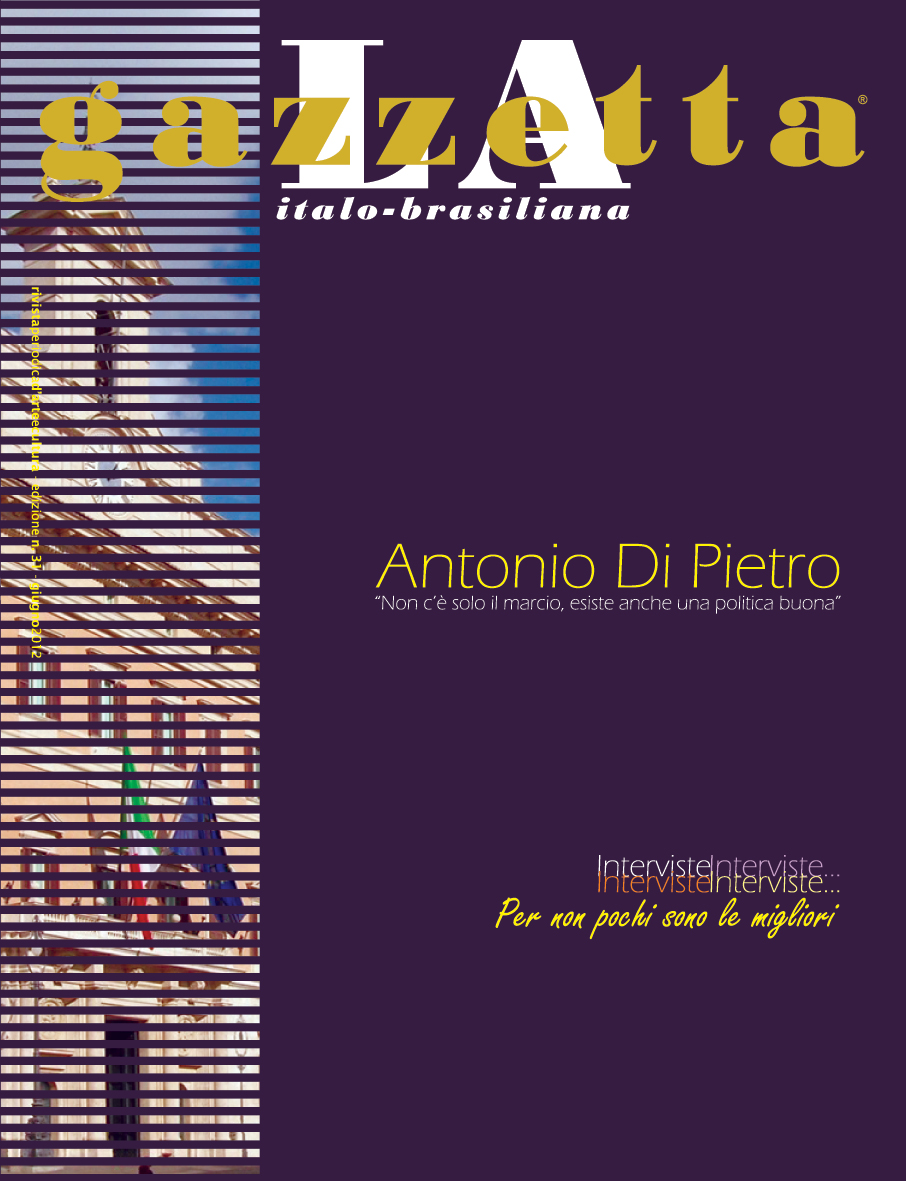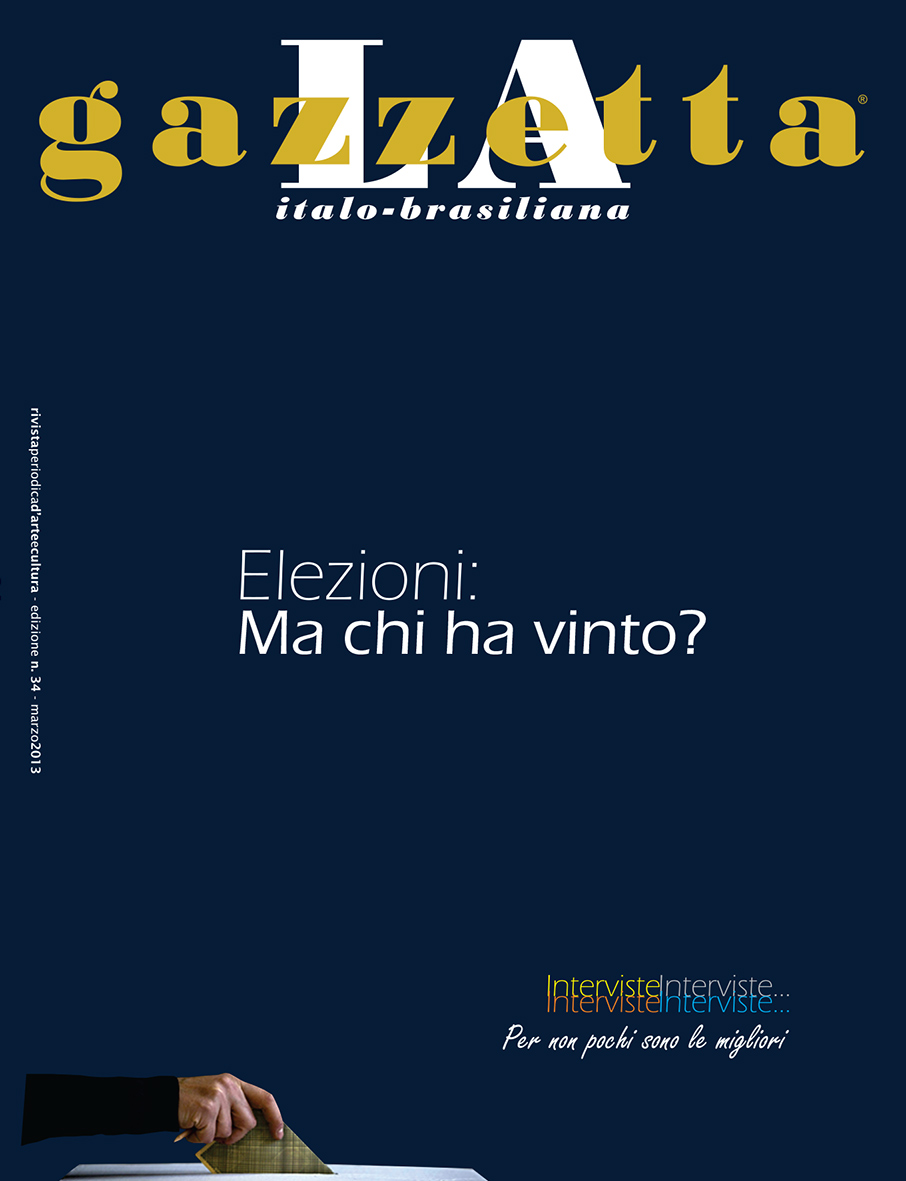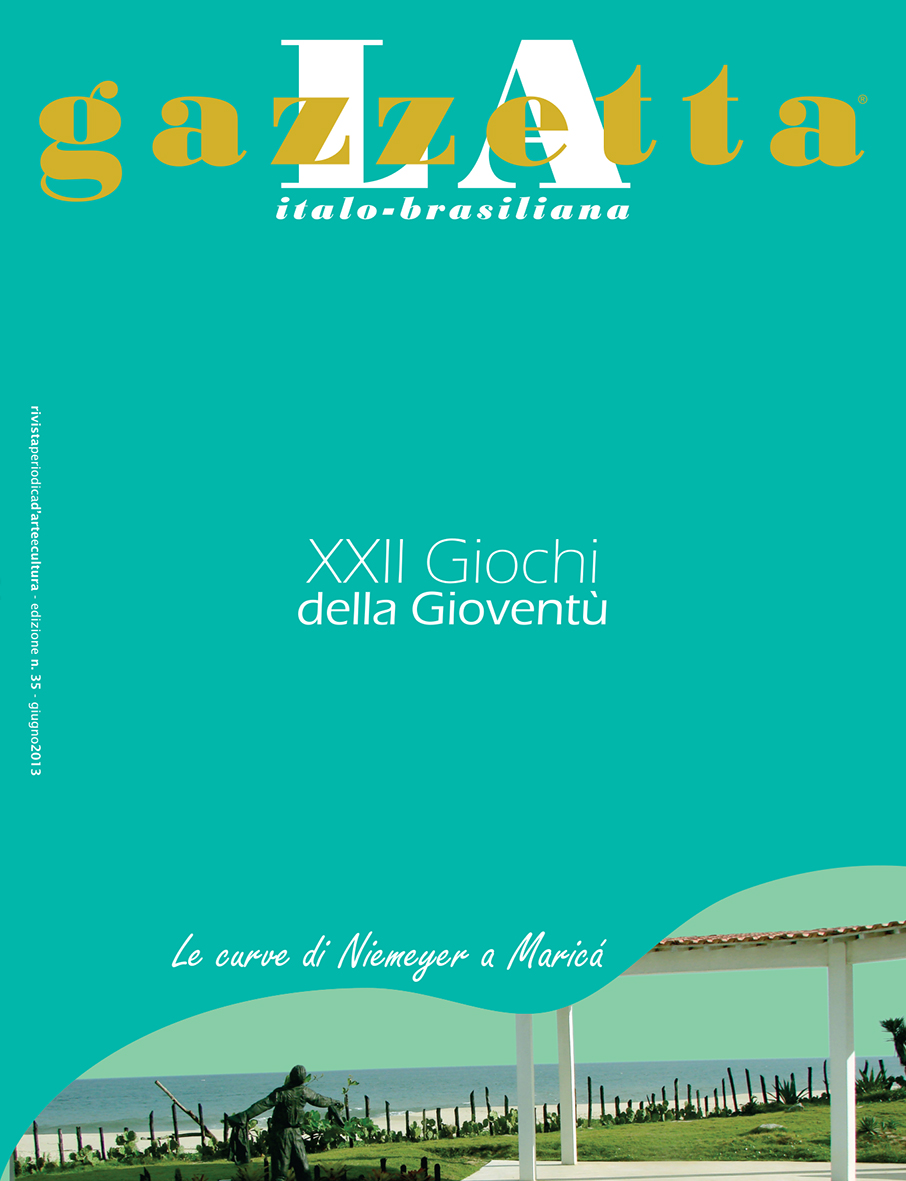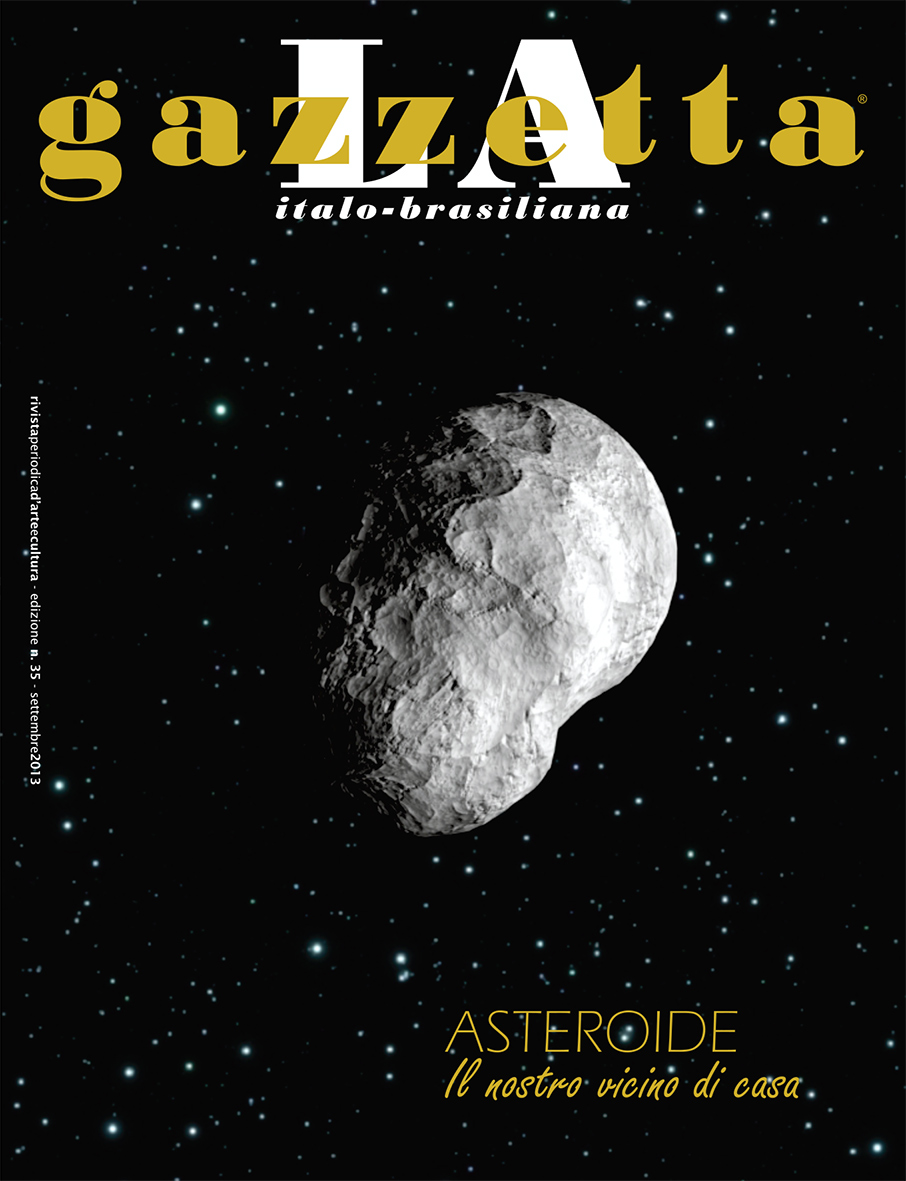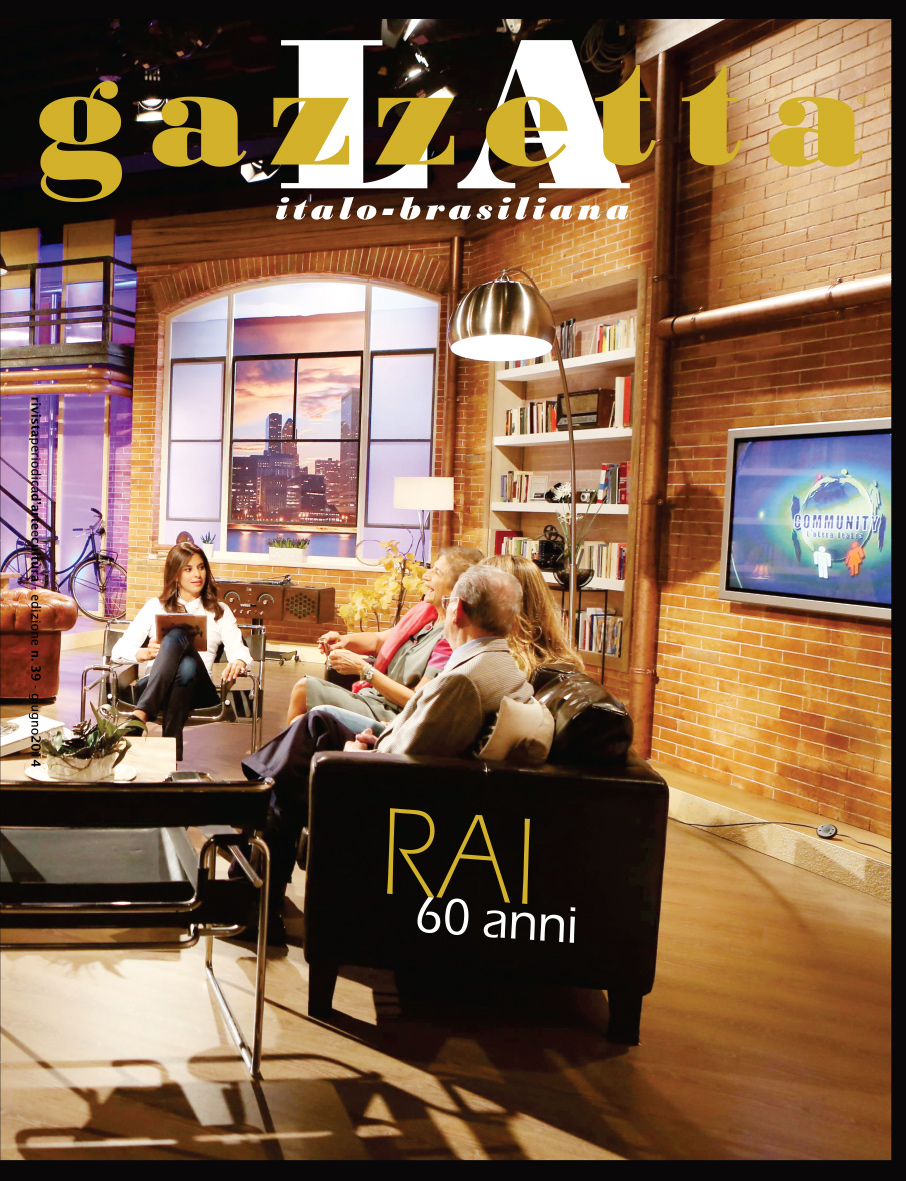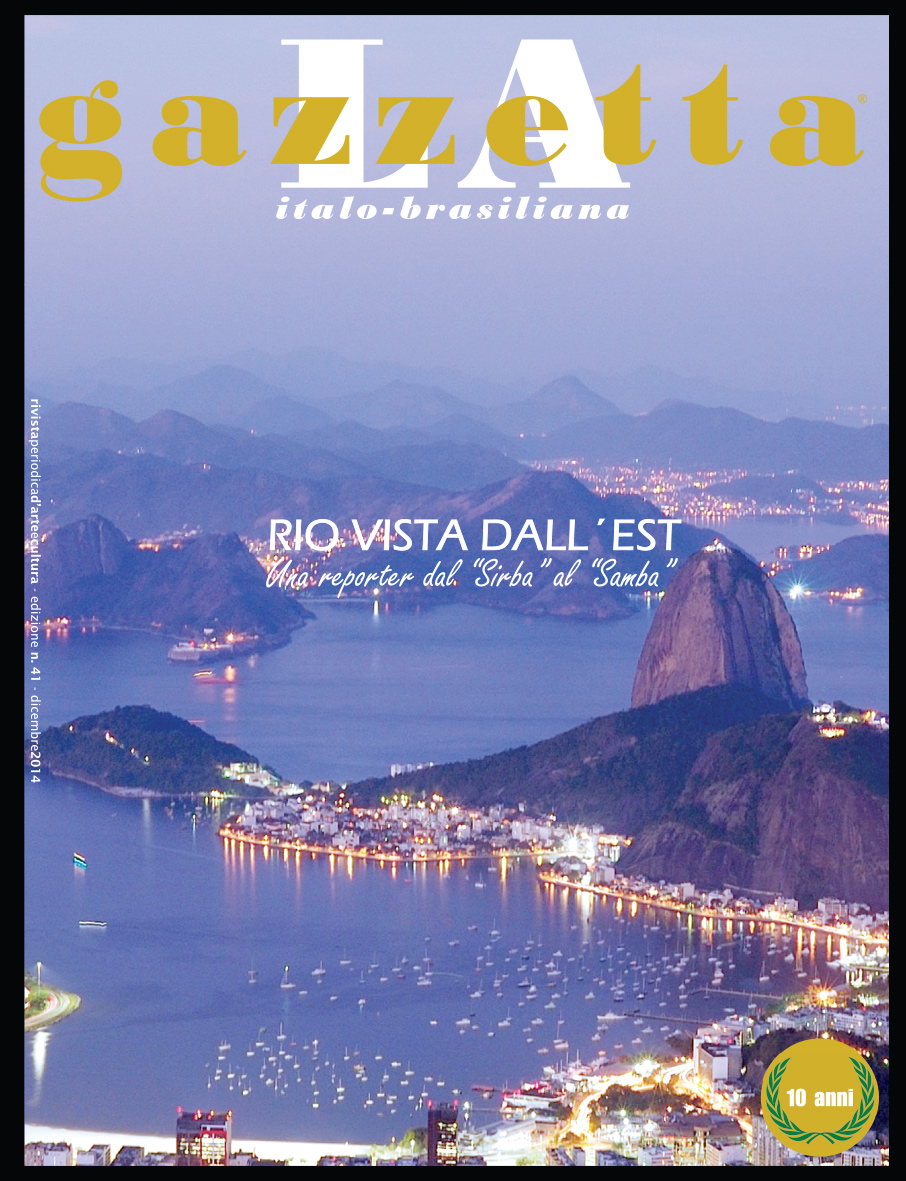Nel cuore del Settecento, la Calabria era attraversata da un complesso intreccio di norme economiche e consuetudini collettive che regolavano la vita delle comunità rurali. I censi, nelle loro diverse forme, rappresentavano un peso economico che gravava sulle proprietà e sulle abitazioni, mentre gli usi civici offrivano agli abitanti un prezioso diritto di accesso alle risorse naturali. Attraverso i Catasti Onciari e le disposizioni pontificie, si delineava un sistema di vincoli che, pur garantendo stabilità economica, spesso si traduceva in gravami permanenti sulle famiglie. D’altro canto, le antiche consuetudini degli usi civici assicuravano alle popolazioni rurali il diritto di pascolo, raccolta e utilizzo delle terre comuni, rappresentando un equilibrio tra necessità economiche e sussistenza collettiva.
Questa ricerca, frutto di un attento e laborioso studio storico, è merito del Dott. Valentino Ussia, a cui va un sentito ringraziamento per il prezioso contributo nella ricostruzione di un capitolo fondamentale della storia economica e sociale calabrese.

Il termine censo (dal latino “censeo”) indicava in epoca romana il patrimonio posseduto dai cittadini ed anche il tributo che costoro dovevano pagare. Pure nei Catasti Onciari del Settecento, in quelli Austriaci del 1724 come nei Carolini del 1741-43, si incontrano sia i cosiddetti censi enfiteutici che quelli bollari, entrambi antiche forme di vincoli gravanti sia sugli “stabili” o “fondi” (così vengono ancora chiamate dalle nostre parti le proprietà agrarie) come anche sulle misere abitazioni di allora.
Il censo enfiteutico era un “peso” detraibile da quanto dovuto alle casse dell’Università di appartenenza ed era un “censo conservativo” in quanto il venditore, alienando lo “stabile”, la casa o il “catòio”, anziché incassare il prezzo hic et nunc, si riservava il diritto di riscuotere un reddito annuo e perpetuo, che gravava il bene come onere reale ed era dovuto anche da terzi subacquirenti.
Rientra nell’enfiteusi anche il contratto di concessione di un bene da parte di un proprietario ad un altro soggetto (enfiteuta) il quale assume l’obbligo di migliorare il fondo e di pagare un canone: il censo enfiteutico, appunto. L’enfiteuta è titolare di un diritto reale su cosa altrui, mentre il concedente è e resta proprietario del bene: conservava, cioè, il diritto di proprietà.
Quello noto come censo bollare era un “censo consegnativo” non era detraibile ed era la prestazione annua a cui si obbligava il proprietario di un bene nel ricevere un capitale: il bene costituiva il pegno del prestito.
L’attributo di bollare o di bullale deriva dalle Bolle Pontificie che, in più riprese, hanno regolato la materia. In particolare ricordiamo quelle di Papa Pio V: Cum onus apostolicae servitutis del 14 febbraio 1568, che disciplinava i contratti di censo sottoponendoli a numerose condizioni; Bolla riportata nei commentari del tempo sotto l’intestazione Literae S.D.N. Pii Papae V super forma creandi census. A questa, meno di un anno dopo e precisamente il 19 gennaio 1569, è seguita la Bolla Reformatio contractuum de annuis censibus, contenente dettagliate disposizioni sui contratti censuari.
Quello che le Bolle non stabilivano, lasciando ogni decisione alle autorità civili, era l’ammontare del tasso d’interesse (la pensio); quest’ultimo, espressamente indicato nell’atto notarile, non poteva comunque eccedere il valore dei frutti prodotti dal bene.
Ma, come spesso accade in questo mondo, per l’attenuazione successiva delle norme più cogenti, la rigida disciplina pontificia fu spesso interpretata in maniera molto estensiva dai teologi e canonisti più favorevoli alla diffusione di tale strumento di credito. E così anche nei Catasti del Settecento vediamo, infatti, che il tasso di interesse dei censi bollari oscilla fra il sette e il nove per cento.
Oltre ai Censi, enfiteutici e bollari, dovuti dalla gran parte della gente, vi erano ancora al tempo dei Catasti del ‘700 altre imposizioni di tipo feudale, di cui non erano gravati i cittadini di Guardavalle e delle altre Università della Contea di Stilo (Camini, Pazzano, Riace, Stignano e, ovviamente, anche Stilo) in quanto territorio regio dipendente direttamente dalla Corona e non da feudatari.
Siffatti gravàmi erano le cosiddette “angarìe” e “corvée”, prestazioni forzose e gratuite imposte a vantaggio del feudatario. Imposizioni ritenute vessatorie ed ancora oggi il termine “angherìa” viene usato con il significato di vessazione: ma la legge del 2 agosto 1806 di Giuseppe Bonaparte, re di Napoli, abolì la feudalità e, con essa, spazzò via tutte le sue imposizioni.
All’opposto delle vessazioni feudali c’erano gli “usi civici”, i quali affondano le loro radici ai tempi dell’Alto Medioevo, epoca in cui le popolazioni, per soddisfare i bisogni primari della vita quotidiana, utilizzavano i boschi, le terre demaniali e quelle non coltivate per raccogliere libera-mente legna, pascolare, attingere acqua da fonti e sorgenti, abbeverare il bestiame, raccogliere i frutti selvatici, l’erba, le ghiande, le castagne, le canne, cacciare, catturare pesci o per raccogliere le spighe rimaste dopo la mietitura (attività, quest’ultima, che ci fa ricordare “La spigolatrice di Sapri”, poesia di Luigi Mercantini ispirata alla fallita spedizione antiborbonica del 1857 guidata da Carlo Pisacane).
Gli usi civici erano diritti costituenti una forma di proprietà collettiva, diritti tradizionalmente noti come ius pascendi, ius aquandi, ius beverandi, ius lignandi, ius venandi, ius piscandi, ius spicandi. Diritti che spettavano agli abitanti non come diritti individuali “uti singuli”, bensì come spettanti alla collettività “uti cives” e che venivano conservati e rispettati anche nei fondi concessi in feudo: “ubi feuda, ibi demania”.
Nella memoria dei più anziani resta ancora il ricordo di questi antichissimi diritti collettivi detti jùssi, al singolare jùssu: anche il vocabolo dialettale, derivato pari pari dal latino jùs-jùris, ricorda le antiche leggi, consolidate dalla consuetudine nella memoria collettiva ed applicabili, oltre che nelle ormai ridotte terre demaniali, anche negli “stabili” non recintati.
Ricordiamo, ad esempio, che non solo “La spigolatrice di Sapri”, ma anche tante e tanti fra i più diseredati si dedicavano a racimolare un po’ di grano, raccogliendo le non molte spighe sfuggite alla falce dei mietitori, avvalendosi dello Jùs spicàndi. Ovviamente il terreno doveva essere stato già abbandonato dai mietitori e sgombrato dei covoni e, dopo le spigolatrici, vi poteva accedere anche chi possedeva qualche capretta per farle brucare i “risùgghj” (le stoppie): quanto poco restava, cioè, degli steli del grano mietuto. Era questo un caso degli antichi diritti dello Jùs pascéndi.
Non vi erano né orologi e, tanto meno, nemmeno clessidre nelle loro sdrucite bisacce: per stabilire i turni notturni per deviare nei rispettivi orti la scarsa acqua dei torrenti, i contadini si affidavano al cadenzato sorgere sull’orizzonte delle costellazioni stellari. Anche lo jùs aquàndi aveva, a sua volta, le sue leggi.
Non si poteva (e non si può nemmeno adesso, ovviamente) tagliare senza regole alberi nel demanio: ma per buona sorte provvedevano allora i venti tempestosi e le nevicate, abbondanti un tempo, a far crollare rami o alberi interi. Era quella la legna che i cittadini potevano raccogliere senza infrangere nessun divieto. Era lo Jùs lignàndi al quale potevano fare ricorso, per fortuna, anche le famiglie non in possesso di un boschetto di loro proprietà.
Sono, questi, alcuni casi esemplari. Come l’istinto spinge le laboriose, instancabili api a racimolare qualche granello di polline e qualche stilla del preziosissimo nettare, che trasformeranno in miele allo scopo di nutrire le loro larve e far in tal modo sopravvivere la stirpe, così anche i nostri antenati (per libera scelta e non per istinto) in quei tempi grami, talvolta anche a stomaco vuoto, si affaticavano oltre misura per strappare alla terra qualche erba commestibile o frutto che fosse, da imboccare all’affamata prole onde farla sopravvivere in attesa e nella speranza di tempi migliori…
Valentino Ussia