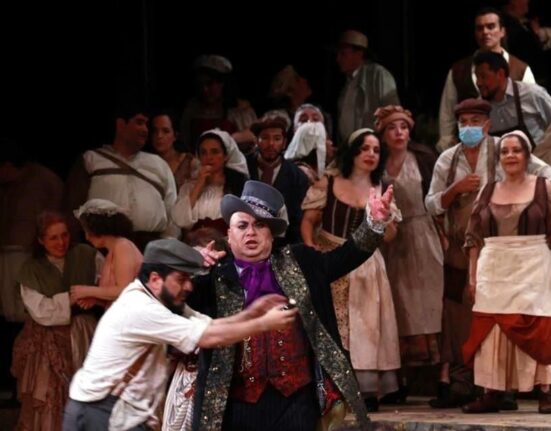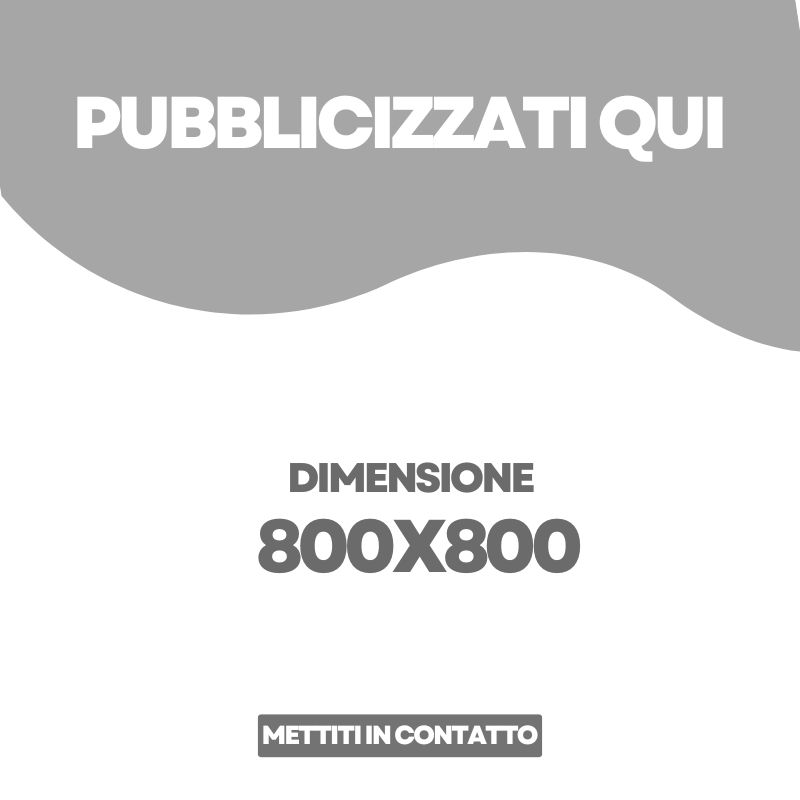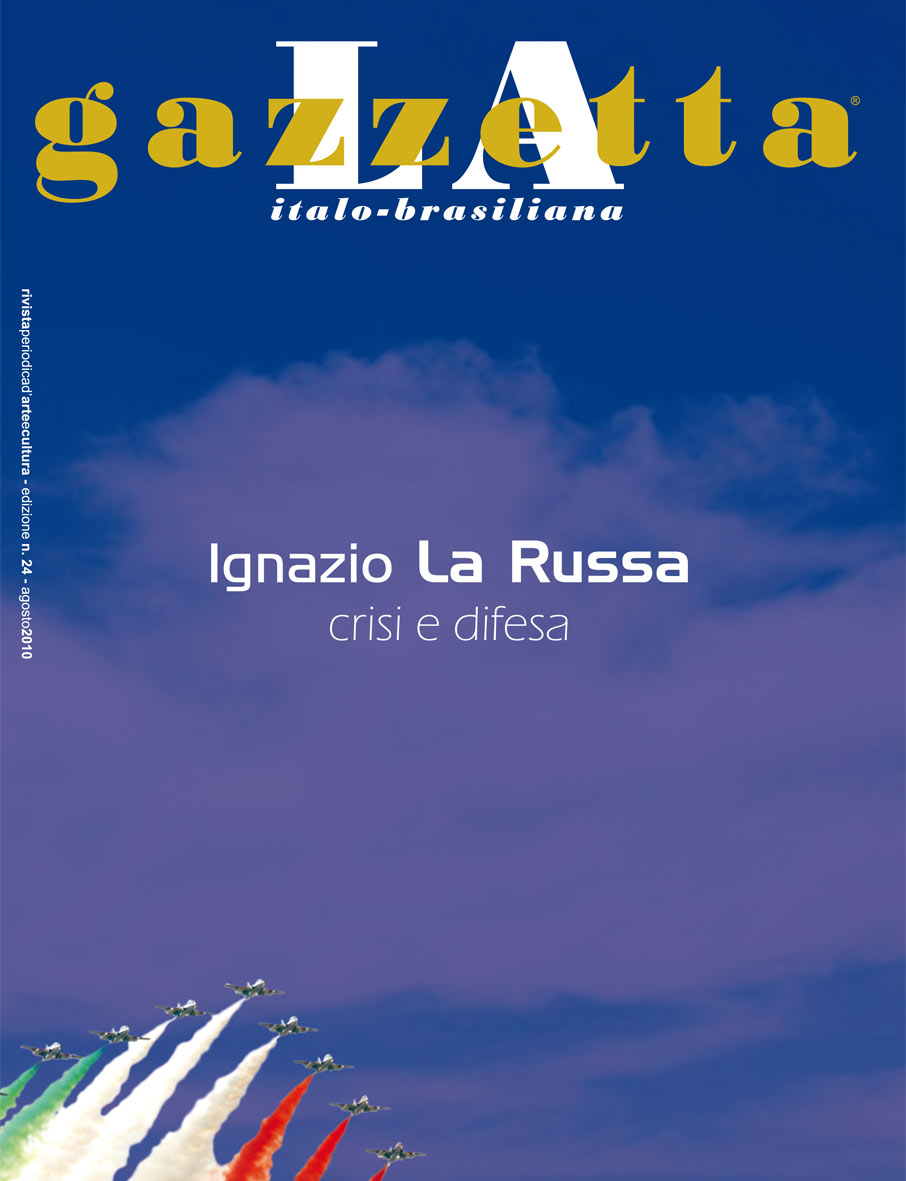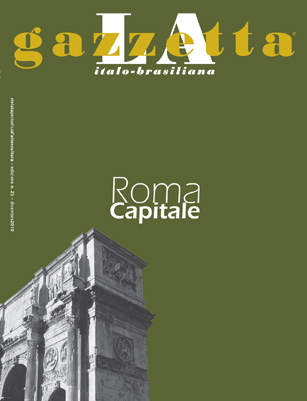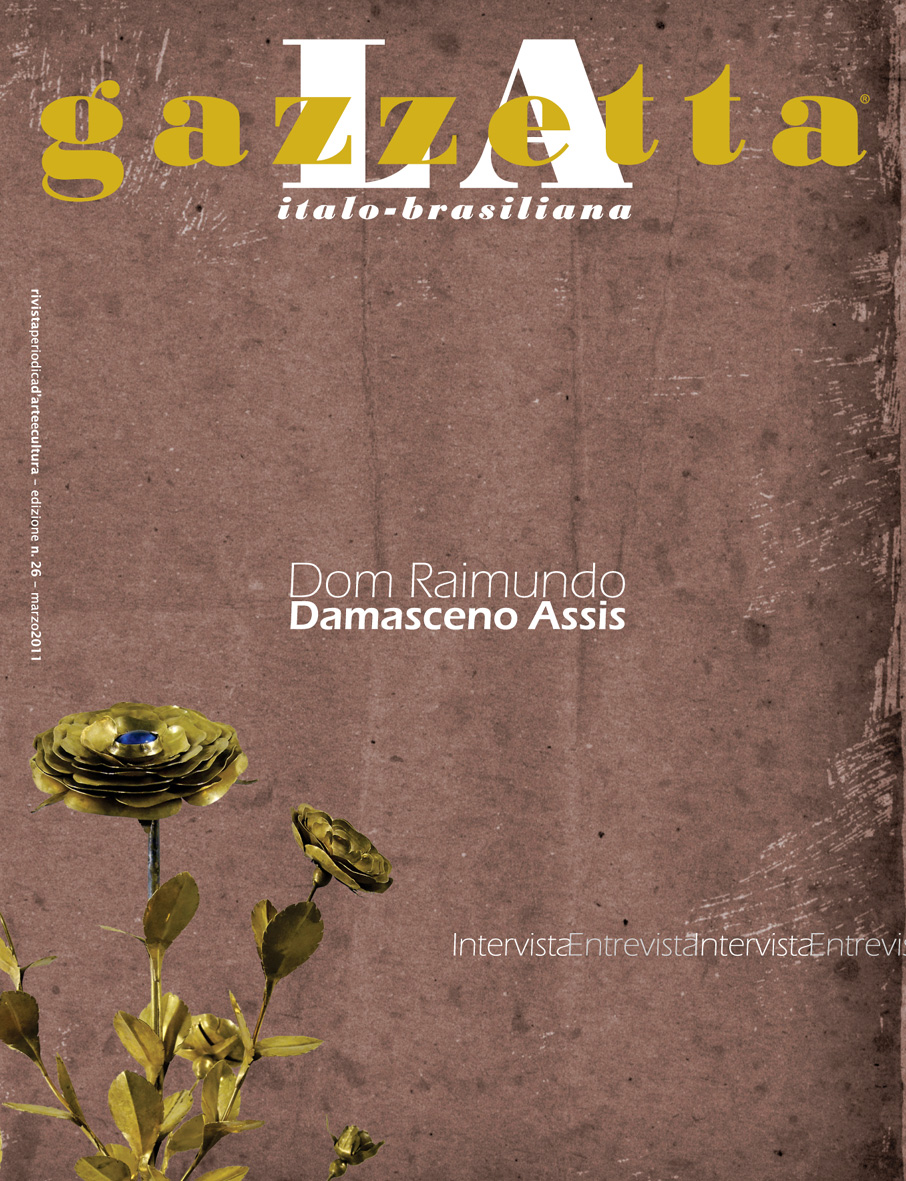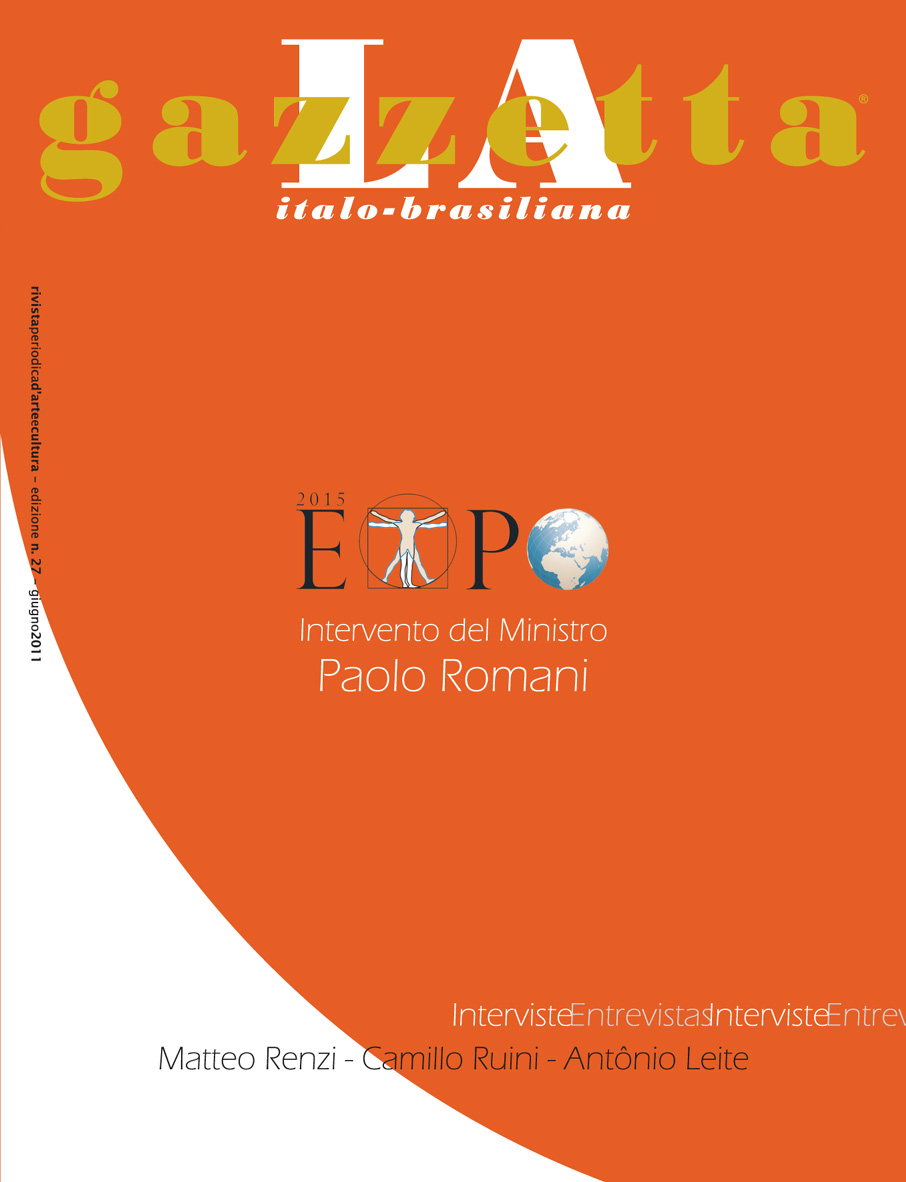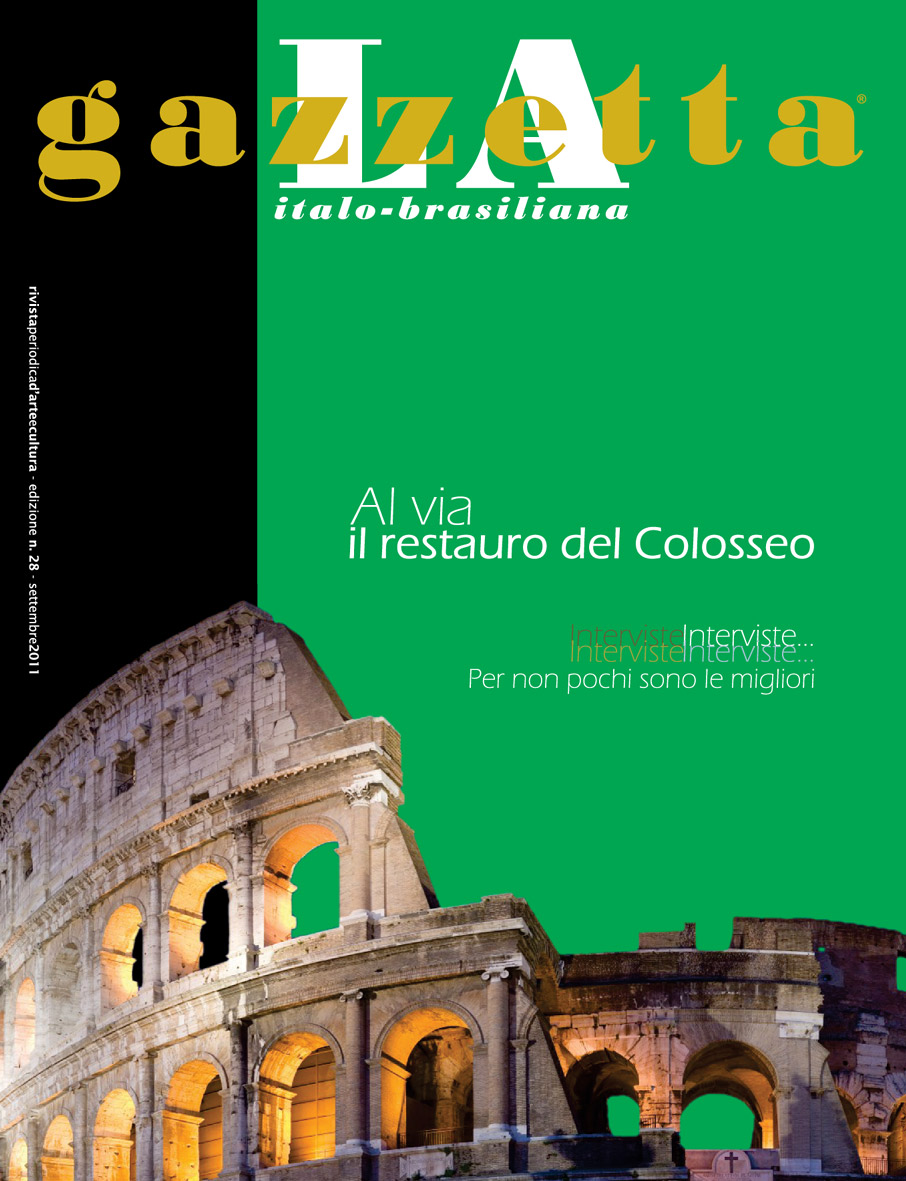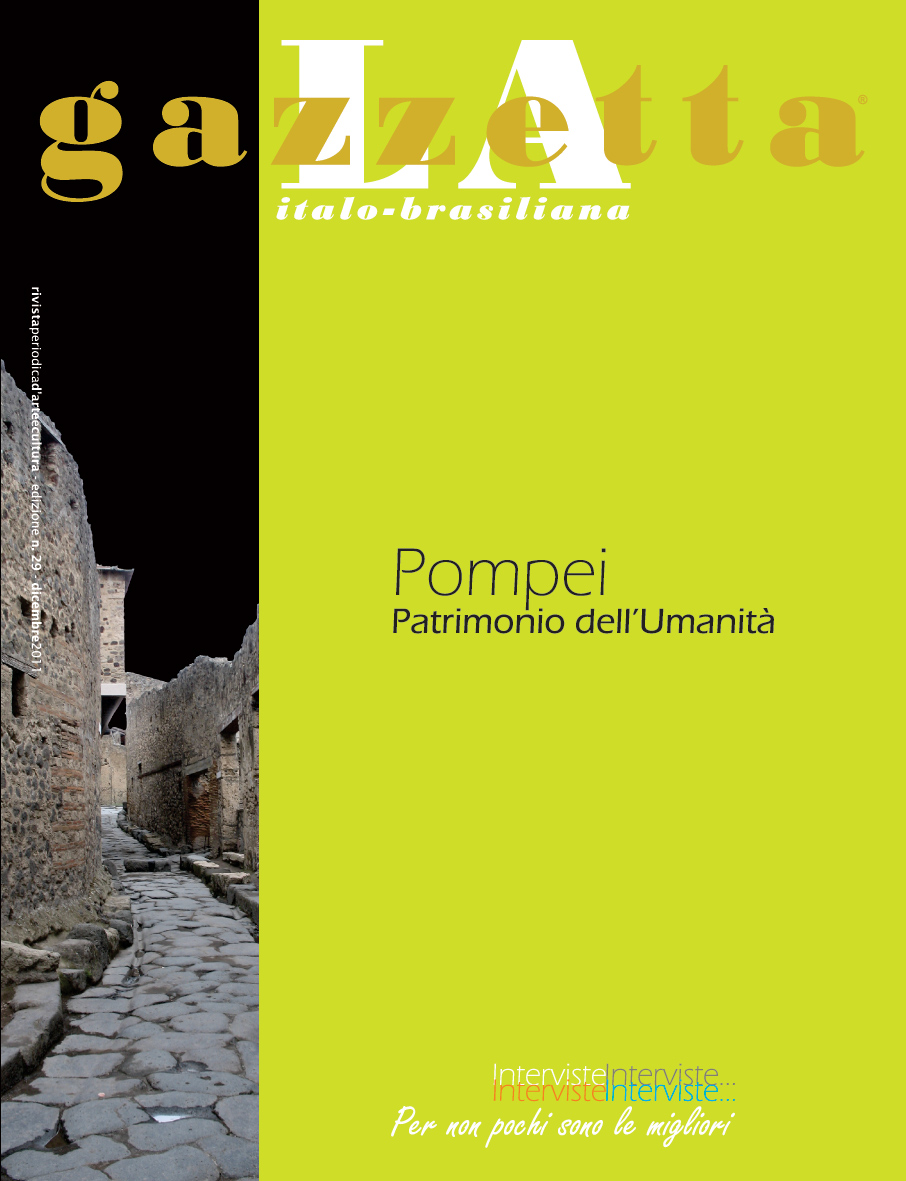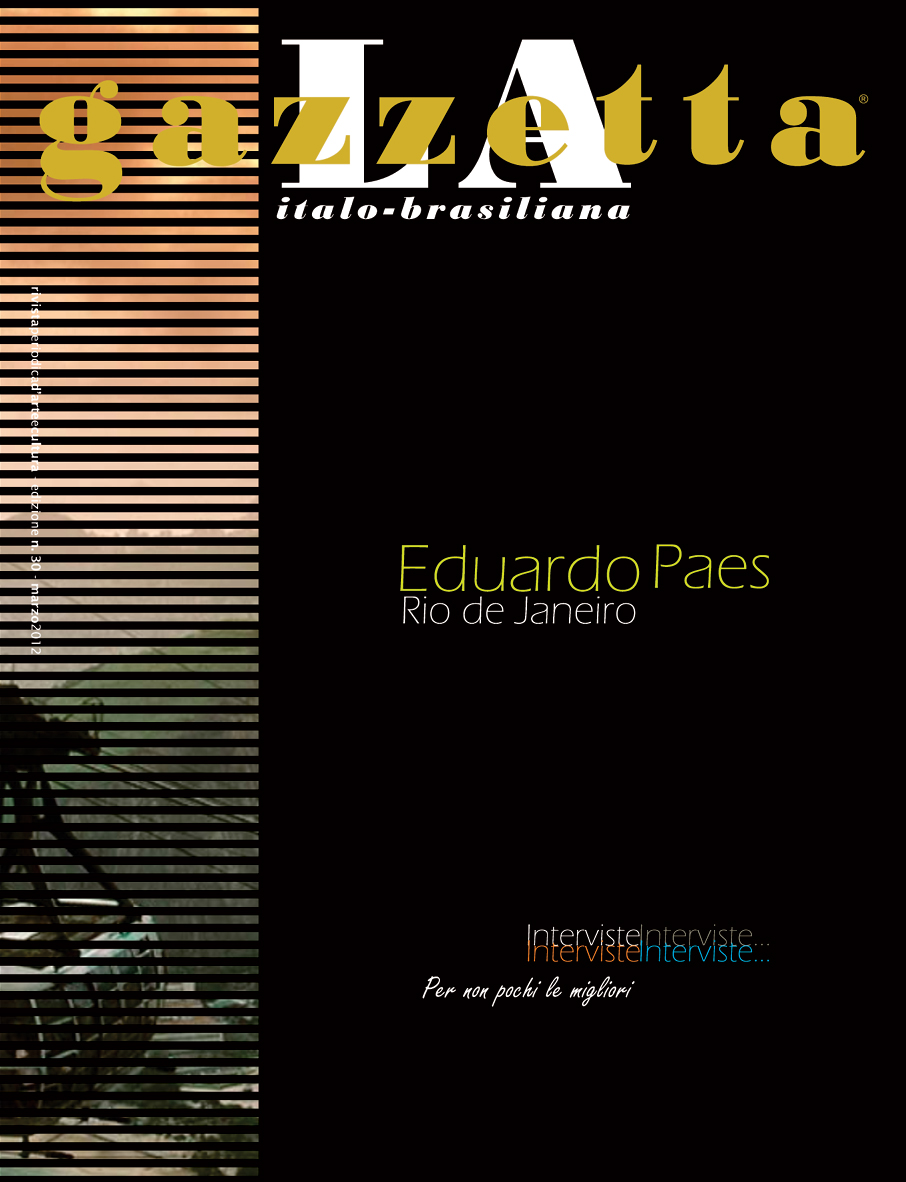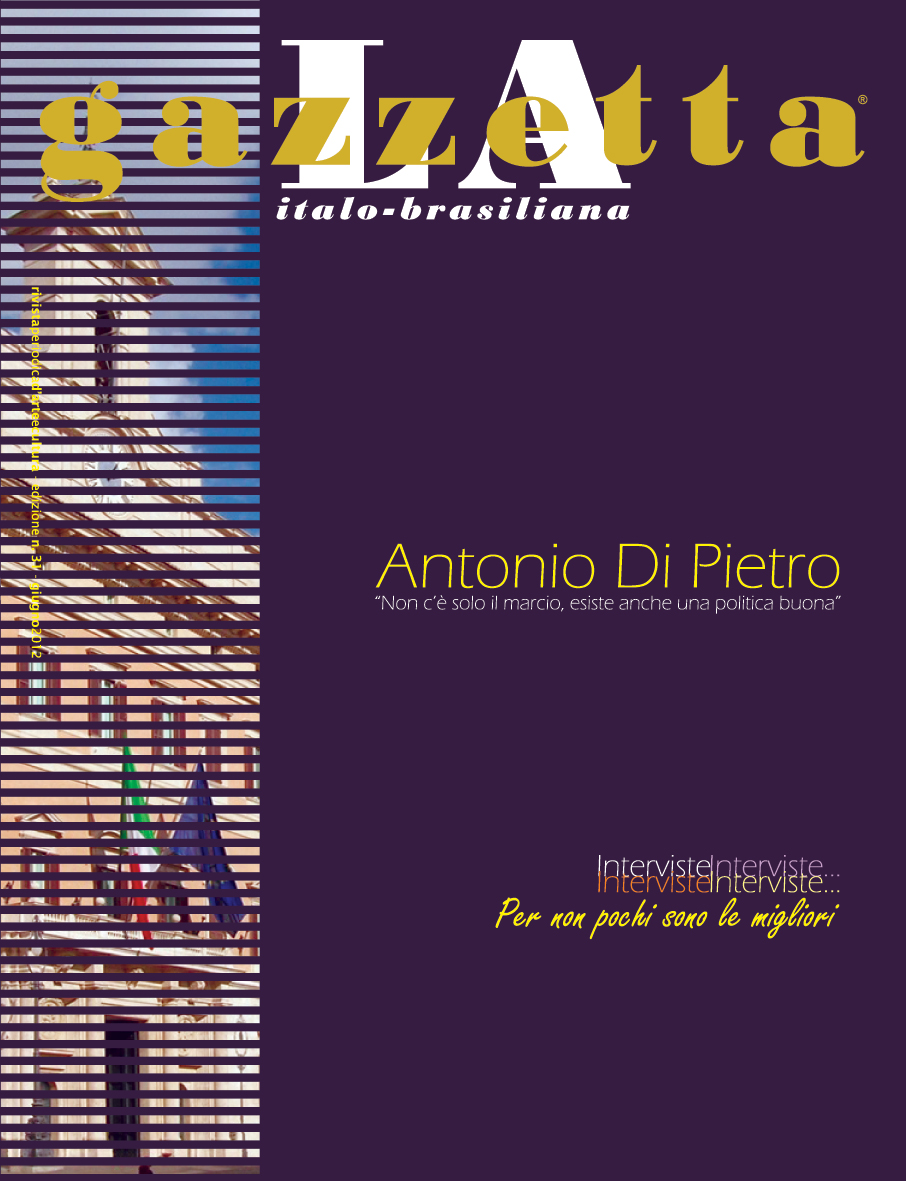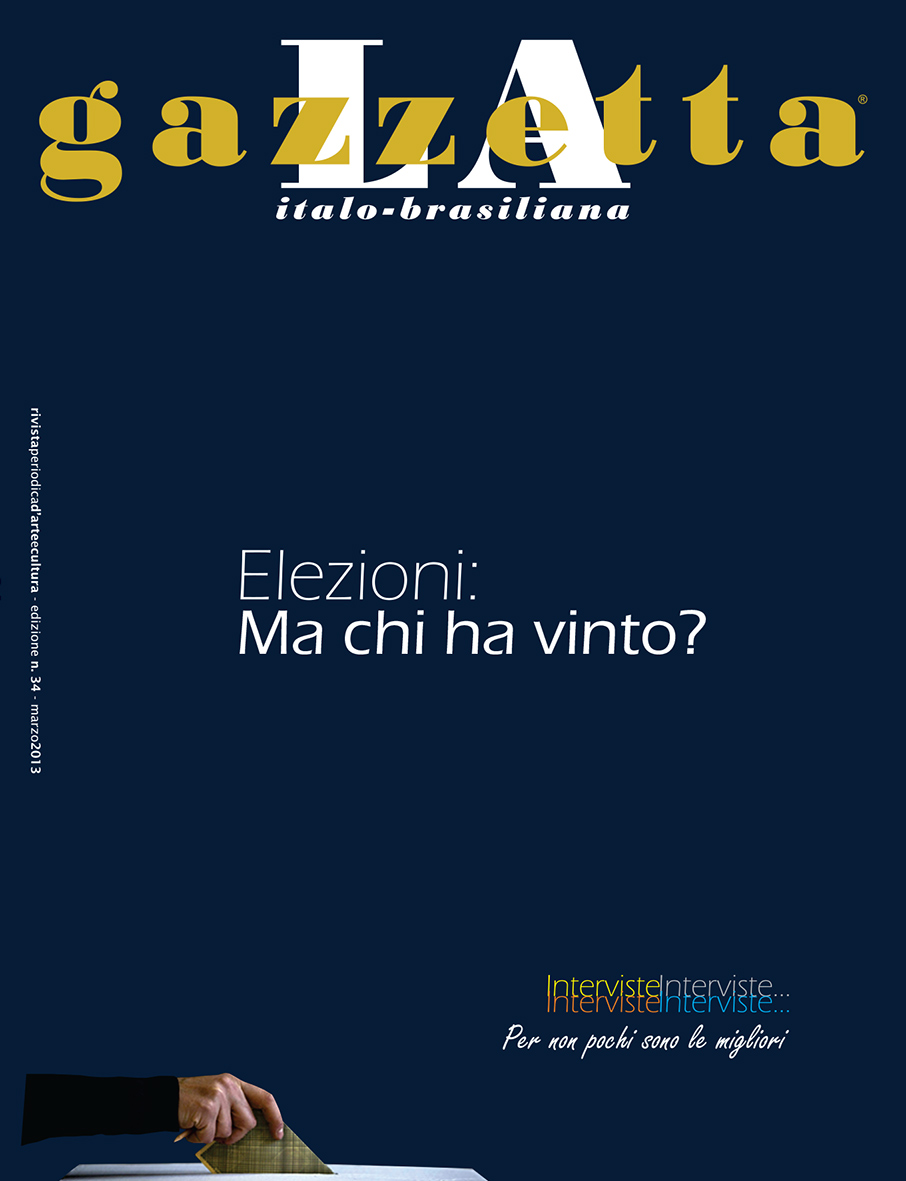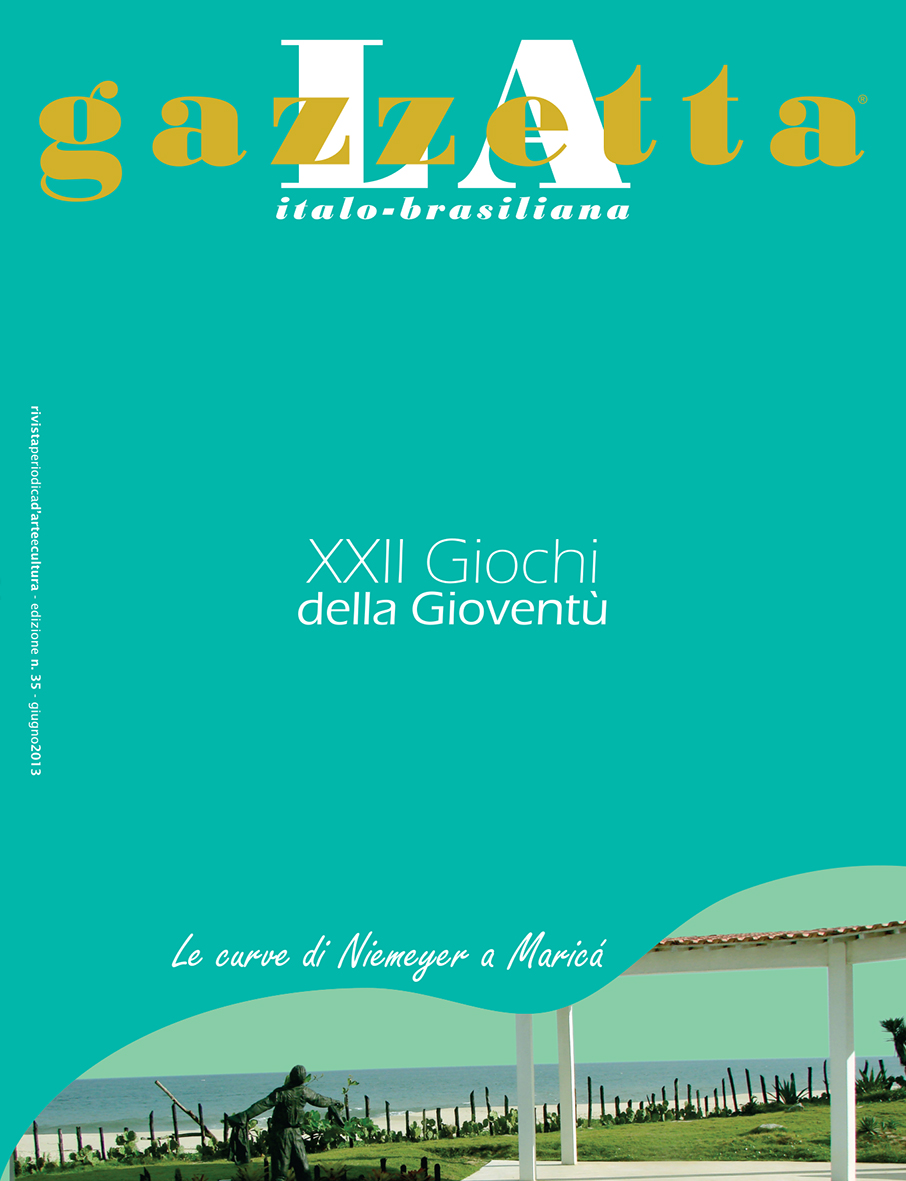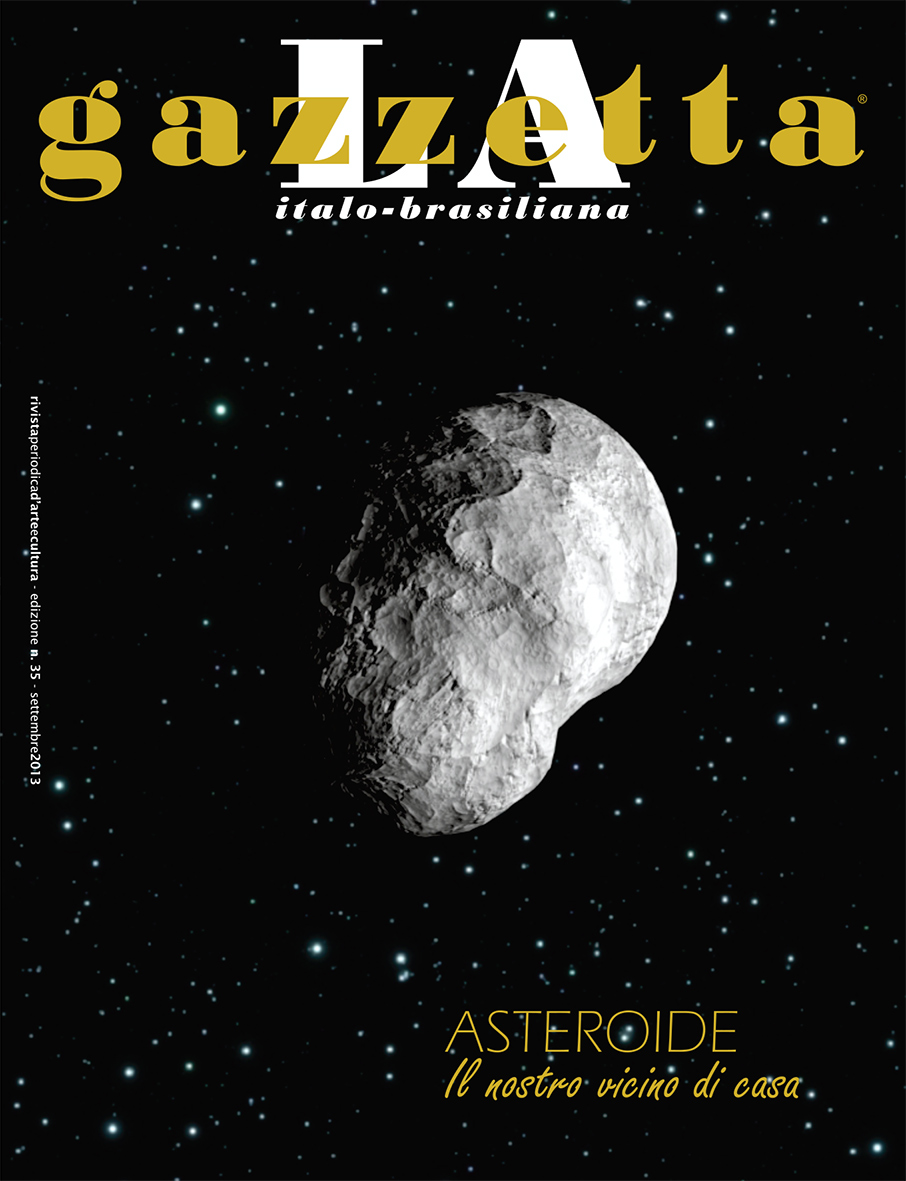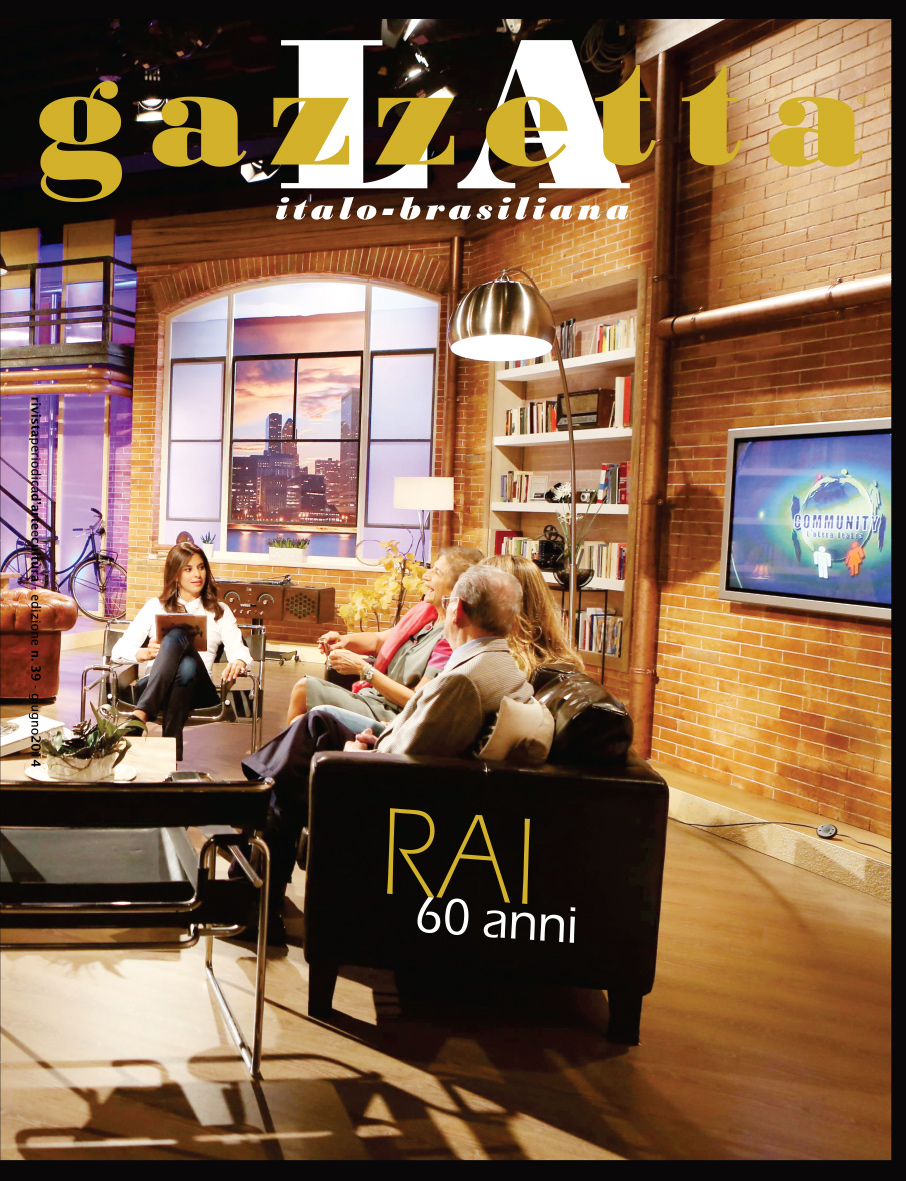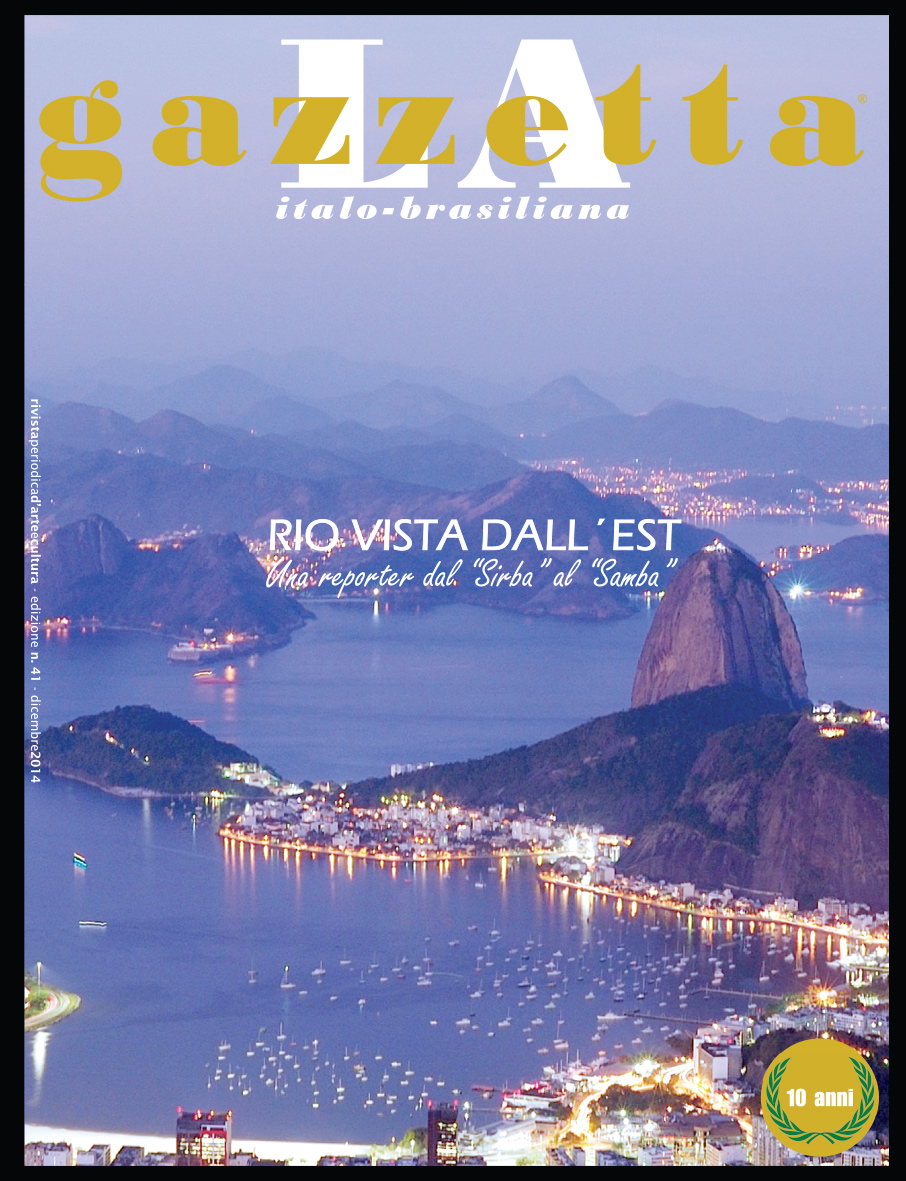In un Paese che da decenni vive una profonda crisi istituzionale, si susseguono dinamiche politiche e sociali che ne compromettono la stabilità e il funzionamento democratico.
L’assenza di una legge elettorale che consenta ai cittadini di scegliere direttamente i propri rappresentanti in Parlamento ha alimentato un bipolarismo artificiale, costringendo i partiti a coalizioni elettorali fragili e spesso ideologicamente estreme, talvolta inclini alla violenza. Piccoli partiti, con percentuali minime di consenso, si sono trasformati in potenze di veto, esercitando un’influenza sproporzionata rispetto alla loro rappresentanza.
La paralisi parlamentare ricorrente ha progressivamente ampliato i poteri del Presidente della Repubblica, attribuendogli un ruolo centrale non solo nella formazione dei governi, ma anche nella gestione dei trattati economici e militari internazionali. A questo si aggiunge la cancellazione di un referendum popolare che aveva sancito la responsabilità civile dei magistrati per dolo o colpa grave, e l’abolizione dell’immunità parlamentare, avvenuta sull’onda emotiva di “Mani Pulite” e del giustizialismo diffuso.
L’elezione per due mandati consecutivi degli ultimi Presidenti della Repubblica ha consolidato un sistema in cui le stesse figure istituzionali si sono protratte al potere, contribuendo a una percezione di immobilismo politico. Parallelamente, numerosi pubblici ministeri hanno sfruttato la propria notorietà per intraprendere carriere politiche, mentre il Paese si è trovato coinvolto in conflitti internazionali (Jugoslavia e Libia) senza alcun voto parlamentare.
Le leggi emergenziali contro terrorismo, mafia e corruzione, ormai in vigore da oltre quarant’anni, hanno dato vita a una sorta di Repubblica penale, in cui la presunzione di innocenza è stata spesso rovesciata in presunzione di colpevolezza, con la carcerazione preventiva utilizzata come strumento di pressione.
L´ultima legge di rigorma sull’attentato agli organi costituzionali ha ristretto il reato ai soli atti violenti, escludendo forme di minaccia non violenta ma comunque pericolose per la democrazia. Intanto, l’editoria, la stampa e le televisioni sono finite nelle mani di pochi imprenditori, talvolta con passati opachi, e di giornalisti schierati che alimentano tensioni e faziosità politica.
Scandali come quello del CSM con Palamara e casi come Striano-Laudati sono scivolati via senza conseguenze significative. In settant’anni, l’Italia ha visto alternarsi ben 63 governi, a testimonianza di una cronica instabilità.
In questo contesto, le emittenti LA7, RAI 3 e SKY, dall’insediamento del governo Meloni, dedicano ampio spazio alla narrazione del ventennio fascista, del nazismo, delle leggi razziali, del delitto Matteotti e della Resistenza, coinvolgendo storici e giornalisti, spesso dichiaratamente di sinistra, nel tentativo di alimentare l’allarme antifascista. Tuttavia, il vero timore non sembra essere un ritorno al fascismo, bensì la possibilità che Giorgia Meloni, non compromessa con i regimi passati, possa ristabilire ordine nel caos istituzionale che opprime il Paese da decenni.
Questo disordine è stato strumentalizzato dagli “Ottimati”, una élite arroccata nei palazzi romani, che ha occupato i vertici dello Stato e consolidato il proprio potere attraverso privilegi e intrecci invisibili. Queste dinamiche hanno permesso loro di esercitare una costante “moral suasion” sugli eletti in Parlamento, salvaguardando la propria influenza.
La Presidenza della Repubblica si trova talvolta a compiere dichiarazioni pubbliche che cercano un equilibrio tra il rispetto dei principi costituzionali e le esigenze del contesto politico.. In questo modo, corporazioni influenti come magistratura, stampa e apparati militari hanno minato l’equilibrio dei poteri, relegandolo a un ideale ormai disatteso.
Si comprende allora perché, solo negli ultimi trent’anni, la nostra Costituzione venga celebrata come “la più bella del mondo” e difesa strenuamente da chi trae vantaggio dall’attuale sistema.
![]()